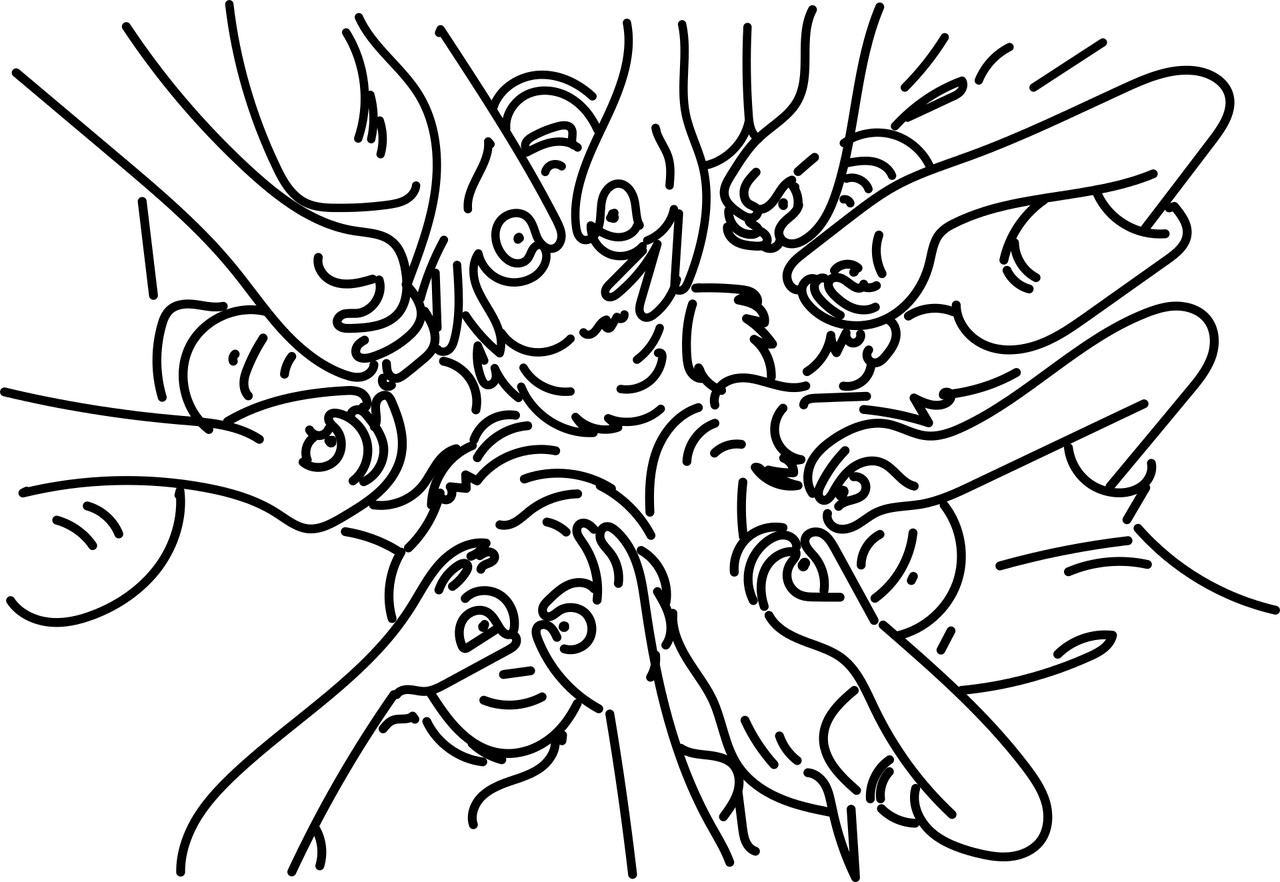Percorso training per l'addestramento all'uso della sedia a ruote
F. Casola - E. Gaiatto
Nell'area verde dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitativa “Gervasutta”, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha realizzato un percorso riabilitativo in contesto ecologico di addestramento all’uso della carrozzina e alla deambulazione.
Il percorso, frutto della collaborazione tra noi architetti, le terapiste occupazionali dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitativa, il Centro Regionale d’Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità e i servizi tecnici dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato progettato con parametri utili in riferimento a test di valutazione validati per misurare i progressi riabilitativi sia per l’uso della carrozzina (ad esempio col “Wheelchair Skills Test”) che per la deambulazione (ad esempio il “Walking Index for Spinal Cord Injury”).
Perchè un percorso training per l'addestramento all'uso della sedia a ruote?
Il circuito permette alle persone in riabilitazione, sia adulti che minori, di implementare le loro abilità di gestione della carrozzina o di cammino usufruendo in sicurezza di un percorso strutturato secondo una progressione graduale e programmata delle difficoltà da superare, aumentando l’endurance e le abilità di performance.
L’utilizzo della carrozzina manuale o di ausili per la deambulazione, quali tutori o deambulatori, risultano fondamentali per promuovere la partecipazione ed il reinserimento sociale, oltre che per la ripresa dell’attività lavorativa e scolastica.
Le persone che utilizzano questi ausili devono padroneggiare una serie di abilità per potersi muovere non soltanto all’interno della propria abitazione ma anche in spazi urbani che spesso implicano il superamento di barriere architettoniche (rampe, gradini e percorrenze su terreni di diverse caratteristiche).
La capacità di superare questi comuni ostacoli presenti negli ambienti urbani ed edilizi facilita la vita indipendente e agevola l'accesso ad ambienti di socializzazione pubblici e privati, permettendo la partecipazione alla vita sociale.
Architettura del percorso riabilitativo
L'area verde
Il percorso è stato progettato nel dettaglio per essere inserito nel contesto di un’area verde esterna dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitativa “Gervasutta”, adiacente ad un'area già attrezzata con orti pensili e, per le attente scelte progettuali, è a tutti gli effetti un progetto di architettura del paesaggio che fonde le esigenze riabilitative con il disegno di un giardino utilizzabile da tutti.
La presenza di alberi ad alto fusto all'interno dell'area verde è stato il presupposto della definizione progettuale sia del tracciato del percorso di training che delle aree con panchine, che affiancano il percorso senza interferire con il tracciato riabilitativo, e che offrono la possibiltà di una sosta durante il training o di trascorrere tempo all'aperto.

Il circuito
Il circuito riproduce alcune delle situazioni disagevoli più comuni con le quali ci si confronta in un ambiente urbano: gradini, rampe di diversa pendenza e piani inclinati, oltre a diverse tipologie di pavimentazioni che rendono complessa la mobilità quotidiana.
Il circuito inizia con un
percorso rettilineo in piano e a raso, caratterizzato da una pavimentazione in con finitura colorata con ossidi in tinta verde.
Lungo il tracciato è presente un doppio corrimano in acciaio inox, con altezza di 95 e 75 cm, che consente di percorrere il percorso in entrambi i sensi utilizzando il corrimano sia con la mano destra che con la mano sinistra.
I successivi tratti del percorso di training propongono il superamento delle più comuni barriere architettoniche presenti in ambiente urbano, appositamente definite e ricreate: il paziente le può affrontare singolarmente oppure può seguire la sequenza proposta dal percorso con il progressivo incremento delle difficoltà.
Le prime barriere da superare che si trovano nel percorso training sono:
- Tratto di percorso rettilineo con pendenza trasversale al senso di marcia pari al 2%
- Area con pendenza trasversale pari al 2%
- Rampa breve di raccordo con
pendenza longitudinale del 5%, caratterizzata da una pavimentazione in calcestruzzo con finitura al quarzo colorata con ossidi in tinta azzurra. La rampa termina con un pianerottolo dal quale, percorrendo una rampa in discesa con pendenza longitudinale del 5%, si raggiunge il “dislivello 5 cm”. Tutto il percorso è delimitato lateralmente da cordoli in calcestruzzo armato.

- Rampa breve di raccordo con pendenza longitudinale dell’ 8%, caratterizzata da una pavimentazione in calcestruzzo con finitura al quarzo colorata con ossidi in tinta gialla. La rampa termina con un pianerottolo dal quale, con rampa in discesa con pendenza longitudinale dell’ 8%, si raggiunge il “dislivello 10 cm” oppure si passa alla “rampa con pendenza 15%”.
- Rampa breve di raccordo con pendenza longitudinale del 15%, caratterizzata da una pavimentazione in calcestruzzo armato con finitura al quarzo colorata con ossidi in tinta rossa. La rampa, attrezzata su entrambi i lati con un doppio corrimano, termina con un pianerottolo dal quale si affronta la “scala di tre gradini”.
Dopo le rampe arrivano i gradini ...
Il percorso azzurro termina con un
dislivello di 5 cm che separa il pianerottolo finale della “rampa con pendenza 5%”; l’alzata del gradino da 5 cm è evidenziata con apposita segnaletica.
Il percorso giallo termina con un dislivello di 10 cm che separa il pianerottolo che conclude la “rampa con pendenza 8%” verso le aree connettive e distributive; l’alzata del gradino da 10 cm è evidenziata con apposita segnaletica.
Il percorso rosso termina con una breve scala composta da tre gradini con pedata pari a 30 cm ed alzata pari a 15 cm; la scala è attrezzata da entrambi i lati con un doppio corrimano in acciaio inox.
... e le pavimentazioni insidiose
Simulando comuni condizioni ambientali sfavorevoli, il percorso propone il superamento di ostacoli che risaltano dalla pavimentazione, come il "risalto" posto trasversalmente al senso di marcia e che si innalza di 2,5 cm rispetto al piano di calpestìo, e la "buca", un incasso nella pavimentazione posto trasversalmente al senso di marcia e profondo 5 cm rispetto al piano di calpestìo.
Per evitare il ristagno d’acqua, il fondo della "buca" è costituito da una canaletta di raccolta collegata ad un pozzetto senza fondo riempito con ghiaia con funzione di drenaggio, posto nell’area verde limitrofa.

L'ultima parte del percorso propone l'attraversamento di 6 aree con pavimentazioni volutamente contrarie alle prescrizioni del D.M. 236/1989 e ai principi della Progettazione Universale in quanto posate -con iniziale sconcerto da parte dei posatori- con modalità esecutive che simulano condizioni di degrado o vetustà.
Il paziente impara quindi le strategie per affrontare:
• lastre in pietra naturale posate a correre
• cubetti di porfido posati a “coda di pavone”
• acciottolato
• gomma antitrauma
• ghiaia battuta
• sabbia
La pubblicazione del progetto del circuito di training
Ad ottobre 2025 il nostro progetto è stato pubblicato all'interno del volume "Strade per la gente: Le persone negli spazi aperti: progetti, pratiche e ricerche per il benessere psicofisico" a cura di C. Cellucci, R. Revellini, V. Tatano, D. Trabucco dell'Univerità IUAV di Venezia ed edito da Anteferma Edizioni Srl.
Per un'anteprima della raccolta e per poter leggere tutti i contributi, il volume è disponibile gratuitamente in versione digitale alla pagina di Anteferma Open Books.
L'articolo che riguarda il nostro progetto, invece, può essere scaricato qui.

PEBA: 5 regole per un Piano agile, da trasformare velocemente in cantieri (e non in cumuli di carta)


Workshop Lido di Staranzano per tutti: valorizzare e promuovere il territorio con l’Universal Design